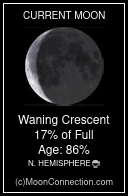Teoria del volo
Per concludere, prenderemo in considerazione alcuni dati elementari della meccanica del volo per dedurne dei criteri per stabilire le reciproche posizioni delle differenti parti dell'aereo: ali, piano orizzontale di coda, impennaggio verticale. Riportiamo brevemente in FIGURA 1 la struttura generale di un aereo nonché le convenzioni relative alle grandezze che caratterizzano la dinamica del volo: forze e spostamenti.
Una condizione affinché il volo possa sussistere - ciò di cui ora dovremo discutere - è la stabilità: quello che si richiede è che a una qualsiasi perturbazione, supposta piccola, nelle condizioni esterne (ad esempio una raffica laterale), l'aereo sia in grado di rispondere in modo tale da ristabilire l'equilibrio. Dato che le equazioni fondamentali della dinamica per un corpo rigido (conservazione della forza e conservazione del momento della quantità di moto) possono essere formulate come se ogni sollecitazione fosse equivalente a una forza applicata al baricentro più un momento calcolato rispetto al baricentro (da cui si può dedurre il movimento del corpo descrivendolo come il moto del suo baricentro più la rotazione del corpo stesso intorno ad esso), è facile capire già da questo l'importanza del baricentro e della posizione delle varie superfici portanti rispetto ad esso.
Parlando di stabilità, possiamo dividere il problema in "stabilità longitudinale" e "stabilità latero-direzionale": la prima riguarda i movimenti nel piano XZ (piano longitudinale verticale, si veda la FIGURA 1), la seconda riguarda i movimenti nei piani XY e YZ, la cui dinamica si presenta accoppiata.
Cominciamo dalla stabilità longitudinale. Prendendo in esame la FIGURA 2, risulta evidente che la posizione dell'ala davanti o dietro il baricentro influenza la stabilità: se l'ala è davanti al baricentro, una perturbazione che determini un aumento dell'incidenza farà aumentare la portanza (la quale, come visto nel CAP. II, aumenta linearmente con l'aumentare dell'incidenza); questo aumento della portanza determinerà un momento cabrante rispetto al baricentro, l'aereo dunque si muoverà in modo da aumentare ulteriormente l'incidenza e così via: la situazione è di instabilità; se invece l'ala è dietro al baricentro, il momento prodotto da un aumento di incidenza (e dunque di portanza) sarà stavolta picchiante, quindi tenderà a ridurre l'incidenza annullando così la causa dello squilibrio: questa configurazione è dunque stabile.
Parlando della posizione dell'ala rispetto al baricentro abbiamo in realtà semplificato il discorso: vi sono altre superfici portanti (o deportanti), in particolare il piano orizzontale di coda, che danno un loro contributo alla portanza complessiva e quindi al verso del momento totale (il contributo del piano orizzontale è poi tanto maggiore in quanto questo piano, sebbene molto più piccolo del piano alare, è assai distante dal baricentro, essendo situato sulla coda del velivolo). Si definisce a questo proposito il "punto neutro" di un velivolo quel punto nel quale si dovrebbe trovare il baricentro affinché a variazioni di incidenza non corrisponda alcuna variazione del momento sul piano XZ: è il punto limite che separa la regione in cui, ponendovi il baricentro, si generano momenti che tendono ad aumentare le variazioni di incidenza, e la regione in cui si generano momenti che producono l'effetto opposto. Matematicamente, questo punto si trova imponendo che la derivata del momento rispetto all'incidenza sia nulla, ma questo è un punto che qui non svilupperemo. Diremo solo, per concludere, che se non ci fosse altro contributo che quello dell'ala, il punto neutro coinciderebbe col centro aerodinamico dell'ala (ovvero per avere la stabilità si dovrebbe fare in modo che il baricentro sia su questo centro o davanti ad esso); essendovi anche il piano di coda, il cui contributo al momento sul piano longitudinale è rilevante (a causa della lunghezza del braccio, dato dalla distanza tra il baricentro e la coda dell'aereo), il punto neutro si sposta indietro, cosa che permette in teoria di avere il baricentro anche leggermente arretrato rispetto al centro aerodinamico dell'ala.
Non sarà inutile considerare un esempio applicativo, assai semplice e al tempo stesso assai istruttivo, cioè il caso del tutt'ala. Essendo questo aereo privo del piano di coda è necessario per la sua stabilità, come abbiamo appena visto, che il centro aerodinamico dell'ala sia arretrato rispetto al baricentro; questo fa sì che l'aereo in volo sia soggetto costantemente a un momento picchiante (dato dalla portanza moltiplicata per la distanza tra centro aerodinamico dell'ala e baricentro del velivolo); affinché l'aereo non vada in picchiata è necessario equilibrare questo momento, e tale è la ragion d'essere del piano orizzontale di coda negli aerei normali (infatti il piano di coda è deportante, produce cioè una forza diretta verso il basso, e quindi un momento, dato da questa forza per la distanza tra baricentro e piano di coda, che è cabrante ed equilibra il momento picchiante prodotto dall'ala posizionata appena dietro il baricentro); ma nel tutt'ala il piano di coda è assente, cosicché questa soluzione non è possibile. Allora l'unica possibile soluzione consiste nell'adottare un'ala avente profilo a curvatura negativa, la quale produce un momento cabrante che è proprio quello che ci serve in questo caso (al contrario dei normali profili a curvatura positiva, i quali producono un momento picchiante che andrebbe a incrementare la situazione di instabilità). Ora è noto che un profilo del genere, oltre a produrre il momento cabrante che qui si desidera, produce anche, se si trova a incidenza nulla, un forza verso il basso (al contrario dei profili a curvatura positiva); di conseguenza, per sviluppare una portanza (verso l'alto), è necessario che l'ala sia calettata in modo tale da avere un grande angolo di incidenza (si veda la FIGURA 3), il che rende le prestazioni del tutt'ala generalmente inferiori a quelle degli aerei con piano di coda.
Parliamo adesso della stabilità latero-direzionale. Effettuando considerazioni del tutto analoghe a quelle appena svolte per la stabilità longitudinale, giungiamo facilmente a comprendere altre caratteristiche tipiche dei velivoli. L'angolo diedro positivo (FIGURA 4) produce un effetto stabilizzante perché, supponendo ad esempio che l'aereo sia investito da un raffica laterale da destra, questa configurazione fa sì che nasca un momento di rollio tendente a far alzare la semiala destra; di conseguenza la portanza ruoterà verso sinistra e l'aereo si sposterà verso sinistra, tendendo così ad annullare il vento apparente da destra determinato dalla raffica. È facile rendersi conto che, con angolo diedro negativo, si avrebbe l'effetto opposto: l'aereo andrebbe contro il vento, il vento apparente da destra aumenterebbe e così lo squilibrio si troverebbe incrementato anziché neutralizzato.
Un altro elemento che determina la stabilità o l'instabilità dell'aereo è l'angolo di freccia (FIGURA 5). Con una raffica da destra, la superficie efficace dell'ala destra aumenta, e quella dell'ala sinistra diminuisce (nel caso limite, la superficie efficace è massima quando il vento apparente è perpendicolare all'asse longitudinale dell'ala - che può essere rappresentato dal luogo dei centri aerodinamici dei profili delle varie sezioni - ed è nulla quando è parallela ad esso); quindi la portanza che si produce sulla semiala destra è maggiore di quella che si produce sulla semiala sinistra, il che provoca ancora un momento che tende a far alzare la semiala destra, come nel caso dell'angolo diedro.
Indagheremo infine brevemente l'impennaggio verticale di coda. In primo luogo, esso deve trovarsi sulla coda (o almeno dietro al baricentro del velivolo) perché in questo modo produce un momento di imbardata atto ad equilibrare da situazioni di squilibrio. Riprendendo in considerazione la raffica da destra, l'impennaggio verticale di coda produce un momento che tende a far ruotare il muso dell'aereo verso il vento, e in questo modo gli effetti squilibranti che abbiamo appena discusso tendono ad essere neutralizzati (a prescindere dall'ulteriore contributo stabilizzante dato dai criteri or ora presi in esame riguardo alla disposizione delle ali): si veda la FIGURA 6; è facile rendersi conto dell'effetto squilibrante che si avrebbe invece nel caso in cui l'impennaggio verticale fosse collocato sul muso dell'aereo (o in ogni caso davanti al baricentro). Inoltre l'impennaggio verticale deve svilupparsi al di sopra del baricentro dell'aereo: in questo caso, infatti, la solita raffica da destra produce, oltre al momento di imbardata appena discusso, anche un momento di rollio dello stesso verso di quello prodotto dal diedro positivo o dall'angolo di freccia, con la semiala destra che si solleva e tutto quel che ne consegue; viceversa, se l'impennaggio verticale fosse sviluppato verso il basso, si produrrebbe un momento di rollio di verso opposto, dunque instabilizzante.